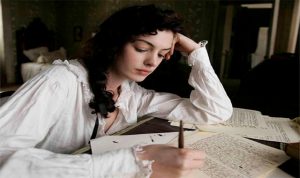 I Romani dicevano “Spes ultima dea”. Ma è ancora così? A leggere le ultime parole di Michele, il trentenne suicidatosi pochi giorni fa nell’ex ricco Nord-Est, non sembrerebbe: «Sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutile. Troppi no. Di “no” come risposta non si vive, di “no” si muore… Io non ho tradito, io mi sento tradito, da un’epoca che si permette di accantonarmi…».
I Romani dicevano “Spes ultima dea”. Ma è ancora così? A leggere le ultime parole di Michele, il trentenne suicidatosi pochi giorni fa nell’ex ricco Nord-Est, non sembrerebbe: «Sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutile. Troppi no. Di “no” come risposta non si vive, di “no” si muore… Io non ho tradito, io mi sento tradito, da un’epoca che si permette di accantonarmi…».
Michele forse ignorava la filosofia di S. Agostino per il quale la speranza non consiste solo nel soddisfacimento di un desiderio (anche se primario come quello del lavoro) e nel ricorso al suicidio quando il risultato tarda a venire o non viene affatto. La speranza, al contrario, richiede un soggetto attivo e volitivo, capace di continuare a vivere e a desiderare facendo affidamento su una ferma determinazione. Non per niente, come si dice, «il verbo sperare non conosce il passivo. Nessuno può essere “sperato” da un altro».
Questa speranza “individuale” dipende essenzialmente da una educazione che dovrebbe rientrare nei doveri della famiglia. Ma questa, spaventata da un presente svuotato da ideali e da un domani imprevedibile, cerca di fare vivere i figli in un mondo ovattato che li tenga il più lontano possibile dal fallimento esistenziale dei nostri giorni.
Così i bambini d’oggi vivono in un modo molto diverso da quello dei loro genitori e nonni. Viene formandosi una generazione “Neet” di giovani che non studiano e non lavorano e hanno pure smesso di cercare, di credere, di volere. Insomma, un popolo di sfiduciati e avviliti.
 Gli adulti, anche se tardi, si accorgono di questa anomalia e cercano di ricondurli alla realtà. Ma invano. I sempre più numerosi Michele, disseminati nel ricco e globalizzato mondo occidentale, non sentono. Essi, con gli occhi fissi sui monitor dei pc e sui display degli smartphone, le orecchie turate non con la cera anti-sirene di Ulisse ma con gli auricolari, le bocche chiuse di chi non ha nulla da comunicare, sono solo fisicamente vicini. In realtà sono lontanissimi, pronti a spiccare un volo dal quale non torneranno più.
Gli adulti, anche se tardi, si accorgono di questa anomalia e cercano di ricondurli alla realtà. Ma invano. I sempre più numerosi Michele, disseminati nel ricco e globalizzato mondo occidentale, non sentono. Essi, con gli occhi fissi sui monitor dei pc e sui display degli smartphone, le orecchie turate non con la cera anti-sirene di Ulisse ma con gli auricolari, le bocche chiuse di chi non ha nulla da comunicare, sono solo fisicamente vicini. In realtà sono lontanissimi, pronti a spiccare un volo dal quale non torneranno più.
Una visione troppo pessimistica della realtà? No, questa è la realtà. Facciamocene una ragione e smettiamola di prenderci in giro. Soprattutto, evitiamo tardive e ridicole giustificazioni del tipo «L’ho sempre accontentato… Ha avuto sempre tutto…». È proprio questo il problema: dare ai ragazzi tutto quello che chiedono!
In una società che si affanna a trovare la strada per un futuro migliore, ad uscire dalle pastoie di una economia malata, ai giovani si presentano due alternative: lottare per l’affermazione di sé affrontando una competizione feroce che l’induce a ricorrere anche alle droghe pur di primeggiare. Oppure arrendersi lasciando che i giorni fluiscano nell’indifferenza e nella noia.
 Davanti a questo bivio è normale che scelgano la via più comoda. Rimane inascoltata la raccomandazione di Tiziano Terzani: «Se ti trovi davanti due strade, una che va in su e una che va in giù, prendi sempre quella che sale».
Davanti a questo bivio è normale che scelgano la via più comoda. Rimane inascoltata la raccomandazione di Tiziano Terzani: «Se ti trovi davanti due strade, una che va in su e una che va in giù, prendi sempre quella che sale».
Fortunatamente, tra questi due estremi, c’è ancora una gioventù “normale” che, senza abbandonare la dea Spes, riesce a trovare un posto (anche se non proprio quello ideale) nella società.
La colpa di questa situazione? Sicuramente è degli educatori in senso lato e della famiglia in particolare. Costoro, in specie i genitori, devono lasciare ai bambini margini di autonomia. In questi anni, invece, essi crescono in un regime di massima sicurezza che controlla con ossessione ogni momento della loro vita (ivi compresi diari e messaggini…).
Di fatto non sono liberi di fare nulla. Vengono accompagnati e ripresi dalla scuola, dalle palestre, dalle festicciole in casa degli amichetti. Viene così impedito loro di guardarsi intorno, di ascoltare per strada i discorsi dei grandi, di accorgersi delle differenze caratteriali tra maschi e femmine, di fare una partitella e magari sbucciarsi le ginocchia o rimediare un bel bernoccolo, di cimentarsi con la prima sigaretta…
E man mano che si va avanti con l’età, i genitori, sempre loro, “consigliano” la scelta di un indirizzo scolastico, di una disciplina sportiva, di un autore da leggere, della carriera da intraprendere, del partner a cui legarsi per la vita. Deresponsabilizzando quello che oramai è diventato un giovane adulto. Soprattutto togliendogli la speranza della speranza. Quando invece la vita s’impara solo vivendola.
Prima di parlare della speranza “collettiva” un accenno a quella dei malati terminali.
Forse c’è più speranza in costoro che non nei sani. Probabilmente perché questo tipo di malato trae la forza da una speranza ultraterrena. Per gli atei inossidabili, per contro, è il vuoto assoluto.
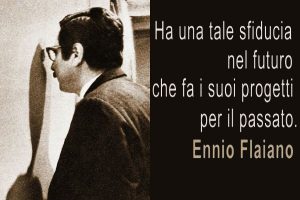 Accennavo a una speranza collettiva che, di fatto, è la sommatoria di quelle individuali. Qui, più che mai, è necessario appoggiarsi agli altri. Infatti perché la speranza di felicità diventi realtà, come afferma la Vegetti Finzi, «è necessario coniugare il verbo “sperare” nella forma plurale del noi: nessuno può essere felice se gli altri sono infelici».
Accennavo a una speranza collettiva che, di fatto, è la sommatoria di quelle individuali. Qui, più che mai, è necessario appoggiarsi agli altri. Infatti perché la speranza di felicità diventi realtà, come afferma la Vegetti Finzi, «è necessario coniugare il verbo “sperare” nella forma plurale del noi: nessuno può essere felice se gli altri sono infelici».
Purtroppo anche con la speranza collettiva le cose non vanno bene. E non potrebbe essere diversamente. La sfiducia si è impossessata dell’anima del Paese che sembra precipitato nella decadenza materiale e morale culminata nel sacco di Roma da parte dei Goti di Alarico nel 410.
Così non si ha più speranza in un’epoca di molesti sciovinismi e sguaiati nazionalismi e, in particolare, in una Europa che, mettendo in secondo piano i temi economico-finanziari, si preoccupi di pensare di più ad una unità politica e al benessere concreto di oltre mezzo miliardo di cittadini.
Viene meno anche la speranza di una vera fratellanza che, anziché alzare anacronistici muri, allarghi le braccia dell’accoglienza verso coloro – e questo è veramente il fatto che fa pensare – hanno ancora la speranza di recuperare la loro dignità.
 E per rimanere vicini alla nostra realtà locale, sta esaurendosi anche la speranza di salvare una città che sta affondando nelle sabbie mobili di una amministrazione distratta più dalle esigenze egoistiche e dai giochi di poltrone che dagli interessi vitali della comunità.
E per rimanere vicini alla nostra realtà locale, sta esaurendosi anche la speranza di salvare una città che sta affondando nelle sabbie mobili di una amministrazione distratta più dalle esigenze egoistiche e dai giochi di poltrone che dagli interessi vitali della comunità.
Però la speranza ha sempre incredibili risorse e ad esse bisogna ricorrere prima che diventi disperazione. Soprattutto non bisogna rinunciare a combattere ritenendo il compito inutile. Perché questa mancanza di coraggio sarebbe ben peggiore della perdita della stessa speranza.
Guido Giampietro



No Comments