La mostra delle atrocità (2001)
Traduttore: Antonio Caronia
Editore Feltrinelli (collana Universale Economica)
[…] E andiam di fratta in fratta,
or congiunti or disciolti
(e il verde vigor rude
ci allaccia i mallèoli
c’intrica i ginocchi)
chi sa dove, chi sa dove!
E piove su i nostri vólti
silvani […]
(Gabriele D’Annunzio. La pioggia nel pineto)
L’incipit non è un refuso ma un gioco di rimandi voluto, che è soprattutto un tentativo di spiegare una opera complessa come La mostra delle atrocità, attraverso il suo negativo estetico, ovvero La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio. Chiunque abbia avuto modo di leggere i commenti (scolastici e non) alla poesia del noto decadente italiano, sarà sicuramente incappato nella parola “panismo”, di cui il componimento è la trasposizione in versi. I due amanti corrono per il bosco trasformandosi in creature silvane, divenendo un’unica cosa con la natura circostante. Se la poesia è una esaltazione della fusione fra l’uomo e la natura in un idillio arcadico romantico, La mostra delle atrocità è invece la scarnificata rappresentazione di un panismo che si potrebbe definire “industriale”, in cui gli esseri umani divengono parte integrante del desolante paesaggio post-moderno. In questo romanzo scritto nel 1969, nato come artefatto meta-narrativo infarcito di saggistica e suddiviso in brevi schegge di capitoli, Ballard spinge sull’acceleratore della sua poetica della reificazione, proponendo riflessioni sociologiche destinate a fare scuola per tutte le generazioni a venire.
La mostra delle atrocità è un romanzo clinico, anatomia, psicologia ed architettura si fondono e si scambiano i ruoli. Frutto di questa manipolazione è “l’esplosione” della materia umana che viene analizzata e definita per mezzo dei desolanti edifici ed installazioni che fungono da scenografie: siti di crash test automobilistici, cliniche psichiatriche, piste di atterraggio abbandonate e cimiteri d’auto.
L’aspetto che forse più colpisce, scorrendo il romanzo, è la totale assenza di personaggi “umanamente sensibili”. I protagonisti sembrano manichini intenti a muoversi in uno scenario di profonda indifferenza, su cui domina la violenza psicologica (quella della clinica in cui i malati vengono sottoposti alla visione reiterata di immagini atroci, per comprenderne il potenziale sessuale; o le stranianti mostre in che hanno per soggetti porzioni millimetriche di epidermidi zoomate fino a diventare indecifrabili) e fisica (più volte il protagonista mostra una soddisfazione erotica nell’assistere ai crash test).
In un contesto così perturbante spicca la figura del protagonista dalle innumerevoli identità: Travis, Traven, Talbert, Tallis. Personaggio che cambia più volte nome nel corso della storia, quasi a voler chiaramente indicare una instabilità mentale prepotente. Travis, Traven, Talbert, Tallis è il l’attore principale di un “Truman Show” della follia, i medici lo tengono sotto osservazione , giocano con lui, ne registrano ed analizzano ogni azione o pensiero. La tecnica analitica utilizzata da Ballard si esprime in tutta la sua potenza nei “modi” narrativi. Come detto in precedenza il romanzo è costituito da una serie di brevi paragrafi ed alla struttura già compressa si aggiungono continue citazioni della cultura popolare (auto,personaggi famosi, pubblicità e cartellonistica), che non sono fini a se stesse ma sono tentativi di spiegare quello che sta accadendo all’interno della storia stessa. In questo senso Ballard cattura appieno la tradizione del citazionismo postmoderno, utilizzandola però con l’intento di destabilizzare il lettore attraverso l’instaurazione di relazioni di significato stranianti. La mente di Travis, Traven, Talbert, Tallis è la cartina tornasole del sistema nervoso dell’uomo postmoderno di cui La mostra delle atrocità dà una interpretazione iperbolica, fornendo illuminanti chiavi di lettura del mondo contemporaneo. Una tappa obbligatoria del romanzo postmoderno.
James Lamarina



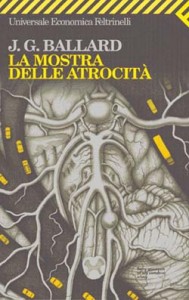
No Comments