È vero che amarsi per sempre – si chiedeva Honoré de Balzac – è la più temeraria delle imprese? Certamente sì se osserviamo ciò che la realtà di tutti i giorni ci offre. Uno spettacolo fatto di separazioni di fatto o legali, seguite o no da divorzi, divorzi brevi, divorzi senza avvocati, divorzi facilitati, divorzi all’estero con assistenza in italiano…
Tutti felici, allora? Macché. Tutti, ma proprio tutti, più infelici, tanto da generare, negli ultimi anni, la categoria dei nuovi poveri. Soprattutto mariti e padri ridotti, dopo la separazione, all’indigenza a causa dell’obbligo degli assegni di mantenimento e del forzato abbandono dell’abitazione. Oltre alla perdita dei figli che le norme del diritto di famiglia assegnano quasi sempre alle madri.
E la drammaticità di tale situazione è sotto gli occhi di tutti perché costoro, se impossibilitati a rientrare nelle famiglie di origine, sono costretti a dormire nelle auto e a consumare i pasti alle mense della Caritas. Che poi non è nemmeno questo l’aspetto più grottesco della vicenda, quanto la perdita, a quaranta-cinquant’anni, della dignità personale. Una triste realtà che li pone sullo stesso piano dei barboni con la differenza che, per la maggioranza di questi ultimi, volontariamente in lotta contro le regole del vivere civile, la perdita della dignità costituisce l’inizio della liberazione.
Si calcola che solo in Lombardia le famiglie che vivono in regime di separazione o divorzio siano quasi un milione e che il sessanta per cento di queste abbia almeno un figlio. E a Milano si stima che siano quasi 50 mila i padri separati che vivono in situazioni di difficoltà economica. Da qui la possibilità offerta dalla Regione di uno sconto del trenta per cento sugli affitti per i genitori separati con Isee inferiore a 20 mila euro o, in alternativa, di un contributo a fondo perduto pari all’85 per cento della spesa per recuperare il patrimonio immobiliare.
Questo avviene nella regione più ricca d’Italia. E altrove? Certamente la realtà è anche peggiore. D’altro canto è evidente che per il sostegno dei genitori separati siano necessarie misure strutturali e non gli spiccioli messi a disposizione secondo il “colore” delle amministrazioni.
Ora non è che voglia fare il “laudator temporis acti”, ma ritengo che in un passato non tanto remoto le cose andassero meglio. Con un divorzio ancora ignoto alle masse, le incompatibilità di carattere si risolvevano con grandi litigate accompagnate dalla classica rottura di piatti e dai lanci (volutamente fuori mira) di stoviglie e libroni. Nei casi più gravi si ricorreva al metodo Lisistrata, vale a dire allo sciopero del sesso da parte delle mogli. Quello stesso che Aristofane, fin dal 411 a.C., aveva messo in scena con successo ad Atene. Alla fine tutto, o quasi tutto, si ripianava. Se non altro per amore verso i figli.
Oggi invece, mentre le parti in causa fanno lavare i loro panni sporchi dagli avvocati o, senza vergogna, li espongono nei talk show, i sociologi si affannano a discettare sulle cause che hanno portato la famiglia – l’unico baluardo che fin qui ha protetto il nostro Paese dal naufragio toccato agli altri – a queste estreme conseguenze.
Se nel passato – dicono – è stata l’occupazione femminile ad assestare un colpo all’istituzione matrimoniale, in quanto una donna che guadagna è più libera di andarsene, oggigiorno sembra siano la mancanza di occupazione e la precarietà a mettere in ginocchio le famiglie. Infatti quando nella coppia uno dei due perde il lavoro non sempre quello sulle cui spalle finisce per gravare l’intero bilancio familiare, è capace di tirare avanti. Così può capitare che uno dei due coniugi trovi altrove qualcuno che lo rassicuri di più.
Ma c’è anche una casistica che fa astrazione dal problema lavoro. Si parla allora d’incompatibilità di carattere, d’incomprensioni, di fine dell’amore.
Direi piuttosto che in questi casi l’amore non sia mai nemmeno principiato o che, anche se in buona fede, sia stato scambiato per qualcos’altro. O che la durata eterna del matrimonio – quella che tradizionalmente si giura in chiesa – nella mutevolezza del mondo moderno abbia perso il suo originale significato.
Ma sul tema dell’amore eterno rischiamo di perderci come il naufrago che intorno a sé non vede più punti di riferimento. Così Goethe, ne Le affinità elettive, faceva dire a un personaggio che il matrimonio dovrebbe essere contratto solo per cinque anni. Di questi, i primi due-tre passerebbero piacevolmente. Poi a una delle parti starebbe a cuore di vedere durare oltre la relazione, e più ci si avvicinerebbe al termine di scadenza, più crescerebbe la piacevolezza.
La «parte indifferente, addirittura scontenta, verrebbe rabbonita e riconquistata da un simile comportamento. Si dimenticherebbe che il tempo passa, come si dimenticano le ore in buona compagnia, e ci si troverebbe deliziosamente stupiti accorgendosi, dopo lo scadere del termine, di averlo tacitamente prolungato».
E una tale teoria, dalla finzione narrativa, è passata nella pratica e spinta alle più inimmaginabili conseguenze. I matrimoni che cessano dopo pochi mesi o addirittura pochi giorni non si contano più. Pur di comparire nei Guinness dei primati si rimane sposati anche solo per qualche ora, dissacrando l’istituto religioso o ridicolizzando il contratto civile che sono alla base del matrimonio stesso.
Una vera e propria rivoluzione iniziata con lo scimmiottamento dei comportamenti hollywoodiani di star e vip e che, nel tempo, si è consolidata perché l’assenza di veri moralisti ha permesso il dilagare dei moralizzatori privi di una visione etica, nel senso laico del termine, della vita.
Perfino la Chiesa potrebbe avere ingenerato qualche dubbio quando nell’Antico testamento (Siracide, libro 25, 26-27) si legge: «Se la donna non cammina al cenno della tua mano, / separala dalla tua carne»…
Naturalmente esistono le eccezioni. Che non sono solo quelle codificate dalla Chiesa nei confronti dei battezzati, vale a dire gl’impedimenti dirimenti, i vizi di consenso e il difetto di forma canonica. E nemmeno quelle dell’ordinamento civile.
Ma anche quelle che si rifanno a rapporti malati contrassegnati dalla violenza e che prima o poi possono concludersi con un femminicidio. Rapporti che con l’unione amorosa non hanno nulla a vedere. Tanto per intendersi, sono lontani dal pensiero che dell’amore aveva il Tasso: «O dolce congiungimento de’ cuori, o soave unione degli animi nostri, o legittimo nodo, o castissimo giogo, che sei più d’alloggiamento che di peso a portare, più di conforto che di fatica a sostenere…».
Naturalmente non rientrano tra le eccezioni le separazioni fittizie suggerite da motivi… fiscali. Quelle cioè che, sfidando la legge, vengono poste in essere per godere di aliquote più leggere.
Dunque, facendo astrazione da tutte le eccezioni, l’unica spiegazione al dilagare della rottura delle unioni matrimoniali rimane quella della mancanza di amore. Amore verso se stessi, verso il coniuge, verso i figli. Una mancanza che, seppure mascherata dalla giovane età e dalle pulsazioni biologiche, c’è sempre stata. Fin dallo scoccare della scintilla dell’innamoramento e, via via, fino al momento del fatidico “sì”.
Insomma bisogna convincersi che è l’amore il collante che tiene in vita il matrimonio facendolo passare indenne attraverso le tempeste della vita. Ed è solo l’amore in grado di sconfiggere l’egoismo che sta alla base delle incomprensioni.
Questo è il senso e il profumo dell’amore che ci hanno lasciato in eredità i nostri nonni prima che il divorzio provocasse le prime crepe all’edificio del matrimonio e la convivenza le ampliasse.
Si potrà non essere d’accordo con questa amara conclusione, ma credo che se si vuole evitare la scomparsa dell’istituto del matrimonio – e con essa il degrado della nostra civiltà – si debba tornare a considerarlo come una cosa seria, molto seria. Al limite della sacralità.
E non si venga a dire “a me questo non può succedere” perché quando non si tiene viva la fiamma dell’amore è naturale che calino le tenebre.
Guido Giampietro


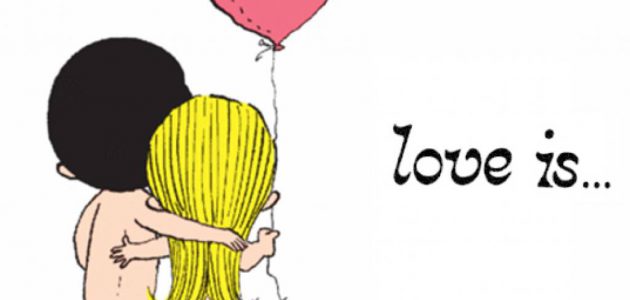
No Comments