LA PIU’ ANTICA, LA PIU’ BELLA FORMA D’ARTE CHE CI SIA/ SIGNORI, ECCO A VOI MADAMA POESIA !
Omaggio ragionato alla Musa Calliope, madre dei nostri sogni
Di Gabriele D’Amelj Melodia
I parte
LE ORIGINI
E’ abbastanza banale da dire, ma è proprio così: la poesia è vecchia quanto noi umani. La poesia nasce con l’uomo perché è un’estensione della sua anima. Ovviamente ai primordi della civiltà va intesa in senso lato: anche i graffiti parietali paleolitici, esprimendo sentimenti, sono una forma poetica, cioè creativa. “ poiein “ in greco attico vuol significare appunto “ creare “. Probabilmente, la poesia sotto forma di versi, sempre legati al suono e quindi al canto, prende forma almeno quattromila anni fa, nella cultura babilonese. All’inizio, e per molti secoli, è strettamente legata al sacro. Un bell’esempio di tale espressione è, nella cultura greca, la TEOGONIA di Esiodo, poema religioso e mitologico composto nel VII secolo a.C.
Nello stesso periodo arcaico, sempre in Grecia, si afferma la poesia EPICA. Non solo Omero con le sue ILIADE ( ) ed ODISSEA, ma anche Eumelo di Corinto, Creofilo di Samo, Arctino di Mileto ed altri. Le imprese degli dei e degli eroi vengono imparate a memoria dagli AEDI e dai RAPSODI, cantori di professione che giravano per corti e piazze. La differenza tra gli uni e gli altri è che i primi cantavano i propri versi ( già, erano cantautori ), i secondi cantavano versi altrui. Entrambe le figure ricordano molto non solo i TROVATORI medievali, ma anche i CANTASTORIE della tradizione popolare.
A braccetto con i poemi epici, si afferma anche la poesia LIRICA, giacché tramandando le storie delle proprie origini, i cantori hanno la possibilità di esprimere anche sentimenti sotto forma di immagini e di figurazioni. I greci chiamavano la lirica “ TA MELE “, ovvero poesia da cantare, e da questa espressione deriva il termine italiano “ melodia “. Ricordo anche che le declamazioni musicali erano sempre accompagnate dal suono della lira o dei flauti dolci.
Nasce sin da quei tempi la concezione di un testo poetico autonomamente musicale e niente affatto subalterno alla musica: il verso è ritmo, creato dalla successione dei suoni e degli accenti delle parole. Siamo già al concetto di metrica, fondamentale nella poesia greca e latina, ma in fondo di tutti i tempi, pur nelle varie differenziazioni ( Elegia, Ode, Canzone, ecc. ).
OMAGGIO A SAFFO
“Così con armonia danzavano le Cretesi / con i teneri piedi intorno all’ara, / la giovane erba in fiore sfiorando dolcemente “
( Come non andare con la mente a quel “ suono liquido dei tuoi piedi “ cantato da Pablo Neruda? La poesia è spesso rimando, citazione più o meno rielaborata, assimilazione e, a volte, semplice coincidenza di fantasia creativa )
Il frammento sopra riportato è una felice traduzione di Salvatore Quasimodo, straordinario nel volgere in lingua italiana i classici versi greci. Il siciliano, per chi non lo sapesse, aveva solo un diplomino di perito geometra, ma, dapprima con l’aiuto di un prete professore ( Monsignor Rampolla del Tindaro ) e poi da solo, da autodidatta, si formò come valente uomo di cultura.Quando raggiunse la notorietà in qualità di poeta, ebbe addirittura la cattedra per l’insegnamento di letteratura italiana, per “ chiara fama “ , presso il Conservatorio di Stato “G.Verdi “ di Milano. Fu proprio lo studio della poesia greca a fargli conseguire una precipua musicalità compositiva: “…E comne potevamo noi cantare / con il pi¬-ede straniero sopra il cuore “( Alle fronde dei salici “ ,magistrale esempio di poesia civile ). Che bella differenza di suono e di ritmo con, per esempio, i versi galoppanti di scuola manzoniana “ Soffermati sull’arida sponda / Volti i guardi al varcato Ticino,/ Tutti assorti nel novo destino,/ Certi in cor dell’antica virtù, …za za zan…( marzo 1821 ):sembra di sentire Otello Profazio, il Principe dei cantastorie “ In quel tempo di guerra lontano/ la Sicilia moriva di fame/ ogni dì cento grammi di paneee/ alla ggente doveva bastar, za za zan!…”……………
Decasillabi incalzanti ormai fuori moda e dal gusto antico, sorpassato. E non è questione di epoca. Nelle prime decadi dell’800, e fino ai primi del ‘900, c’è stao chi si esprimeva con questa tipologia di linguaggio retorica e pomposa…. Se la poesia fosse solo questo o solo quella tirata fuori estemporaneamente da virtuosi dilettanti, avrebbe ben ragione il professore, poeta e critico americano Ben Lerner a lanciare il suo j’accuse provocatorio contro la nobile arte (mi riferisco al casustico pamphlet “ Odiare la poesia “, Sellerio 2017 ), ma fortunatamente c’è ben altro…
IL PIU’ GRANDE DI TUTTI
Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro dei conti Leopardi da Recanati, il gigante che ha fatto sospirare milioni di adolescenti, pur senza essere un mieloso sdolcinato o un cantautore pop. Leopardi, un intellettuale, un filologo e un filosofo e, malgrado questa sua cultura “ mostruosa “ un ineguagliabile cantore dell’animo umano. Un creatore di immagini straordinarie, ricche di un sentimento avvertito, ragionato, eppure magicamente lirico. Un infelice che diventava favoloso, e quindi felice, quando forgiava le giuste parole che poi, assemblate nel testo definitivo, diventavano storia e leggenda.
Emozioni e riflessioni tratte dalla natura matrigna, dalla luna, dalle vaghe stelle. Come dire: l’estetica figlia della sensibilità e dello slancio creativo. Ma quante lacrime e sudore per definire quei capolavori! Basta vedere le tante correzioni operate nei fogli originali di lavoro. Per mesi, per anni. Prendiamo la famosa lirica “ L’Infinito”. Quella sua soave scorrevolezza, la scelta di vocaboli abbastanza semplici e di uso comune, non significano affatto che la poesia sia scaturita di getto, per un afflato spontaneo e intimista. Dietro quell’apparente facilità, oltre al labor limae, c’è tutto un vasto retroterra di cultura classica. Quando compone l’Infinito, nella testa del giovane favoloso riecheggia il Virgilio delle Bucoliche..,.,” Fortunate senex, hic inter flumina nota/ et fontis sacros frigus captabis opacum;/ hinc tibi, quae SEMPER, vicino ab LIMITE SAEPES…ecc…” Ce lo precisa il prof. Nicola Gardini nel suo magnifico saggio “ Viva il latino “,Garzanti 2017 ). E’ la cosiddetta cultura d’assimilazione, per quanto riguarda i paesaggi e la natura bucolica, presente anche in Ariosto, Tasso e persino in Montale. Quello straordinario incipit “ Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l’animo nostro…” ricorda troppo da vicino l’oraziano “ Tu ne quesieris quem mihi, quem tibi finem di dederint, Leuconoe, ecc.,” ( è l’XI Ode, quella del famoso carpe diem ), così come il titolo SATURA dato alla sua raccolta di poesie del 1971. Un caso? Per niente: è solo il riflesso involontario di letture avidamente compiute e metabolizzate.
Ma fatemi tornare per un attimo ancora all’Infinito, giusto per sottolineare come il Leopardi, se fosse nato nel ‘900, sarebbe stato un grande regista.
Continui salti di punta di vista: prima sotto, poi a metà, in fine in cima. E quindi la messa a fuoco su quella siepe, limite fisico e metaforico(Toh, a quei tempi non c’era ancora il demenziale concetto odierno di “ senza limiti “ )E’ lì, ma poi pian piano va in dissolvenza, con un effetto nebbia, il tutto inquadrato con “ piani lunghi “, di “ interminati spazi “. Poi, di colpo, il carrello zooma sulle fronde, il poeta, seduto, sente lo stormire delle foglie e ha quasi un mancamento e si perde nel tempo e naufraga dolcemente.
(continua)
Gabriele D’Amelj Melodia


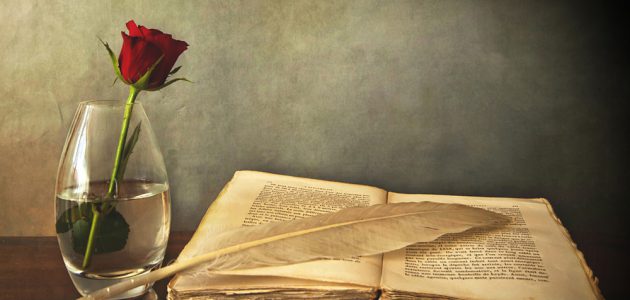
No Comments