Rammentare o dimenticare il passato?
Questo è il dubbio amletico di oggi, non quello dell’essere o non essere. In altri termini: è meglio ricordare tutti ˗ o quasi ˗ gli eventi della nostra vita oppure lasciare che l’oblio stenda un velo su ciò che ˗ di buono e cattivo ˗ abbiamo fatto?
Friedrich Nietzsche è stato uno dei primi ad affermare il diritto all’oblio. In “Considerazioni inattuali” scriveva: «L’uomo invidia l’animale che subito dimentica (…). L’animale vive in modo non storico, poiché si risolve nel presente (…). L’uomo invece resiste sotto il grande e sempre più grande carico del passato (…). Per ogni agire ci vuole oblio: come per la vita di ogni essere organico ci vuole non solo luce, ma anche oscurità. Si deve sapere tanto dimenticare al tempo giusto, quanto ricordare al tempo giusto».
Anche lo scrittore canadese Emmanuel Kattan (“Il dovere della memoria”) ha proposto interessanti riflessioni a proposito delle tensioni che ogni anno si producono nell’Irlanda del Nord nei giorni in cui cattolici e protestanti manifestano, gli uni contro gli altri, nel ricordo della vittoria di Guglielmo d’Orange su Giacomo II, cioè per fatti di oltre trecento anni fa. Senza voler imporci quasi un “dovere di dimenticare”, scrive Kattan, va detto che è impossibile constatare come un’utilizzazione impropria del passato e del sentimento di “credito” nei confronti della storia perpetui i conflitti e generi di continuo nuovi cicli di violenza.
Ma è l’austriaco Viktor Mayer-Schönberger che nel saggio “Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale” ha affrontato di petto la questione. Considerato un esperto di livello mondiale in politica ed economia dell’informazione, in quest’opera si cimenta con un tema d’importanza cruciale, da qualche anno al centro dell’attenzione dei Garanti per la protezione dei dati personali in Europa e negli Stati Uniti: come possiamo controllare la nostra immagine pubblica in un mondo che rischia di negarci, assieme al diritto alla privacy, anche il “diritto all’oblio”, vale a dire quelle regole non scritte che, fino a pochi anni fa, consentivano a chiunque di “rifarsi una vita”, riscattando il ricordo di eventuali errori commessi in un passato più o meno lontano.
Secondo lo studioso l’avvento del digitale ha sovvertito il principio millenario secondo cui dimenticare è la regola e ricordare l’eccezione. L’oblio, per lui, sarebbe una sorta di necessità biologica. Se il cervello non compisse un accurato lavoro di selezione, pescando le informazioni da registrare dalla marea di dati che sommerge i nostri sensi, non potremmo agire.
A saperlo non mi sarei roso dall’invidia per quel mostro di Giovanni Pico della Mirandola. Un tizio dotato di una memoria così prodigiosa da poter recitare la Divina Commedia a rovescio, cioè dall’ultimo verso al primo, dopo averla letta velocemente una sola volta!
Una cosa inconcepibile per me che, da studente, incontravo indicibili sofferenze a mandare a memoria i catastrofici versi del Leopardi o i mielosi brani del Manzoni o le astruse formule di chimica… Quella ripetizione ad alta voce, protratta fino a sera inoltrata, non sortiva, nell’immediato, effetto alcuno. Fortunatamente, al mattino successivo, tutto era inciso nella mente come sul nastro di un magnetofono Geloso. Salvo a dimenticare tutto un istante dopo l’interrogazione.
Potevo mai immaginare, allora, che Pico della Mirandola era, in fondo in fondo, uno sfigato? E che, al contrario, il mio cervello mi stava facendo il favore di non rimanere sommerso da migliaia di dati? A tutto vantaggio del mio cammino incontro al futuro.
Dunque, ricordare è un’attività artificiale e anche costosa, in termini di risorse economiche. Eppure ricordare rende la vita più facile e sicura, permettendoci di fare nostre le conoscenze che altri soggetti, lontani da noi nel tempo e nello spazio, hanno acquisito con l’esperienza.
Per questo abbiamo sviluppato le tecniche di “esteriorizzazione” della memoria: dal linguaggio orale alla scrittura che, attraverso i secoli, si è evoluta ˗ grazie alla stampa ˗ da strumento di ristrette élite a prodotto di massa. Fino a giungere alle tecnologie digitali che, in pochi decenni, hanno cambiato tutto il nostro modo di vivere.
Oggi è infatti possibile duplicare all’infinito testi, immagini, suoni. Per di più a costo zero, senza che le copie subiscano alcuna perdita di qualità. L’informazione analogica richiedeva, per essere condivisa, una grande quantità di strumenti; quella digitale, invece, viene prodotta e distribuita da una sola macchina, il computer, o meglio, i milioni di computer interconnessi che costituiscono un’unica macchina planetaria.
La memoria sociale condivisa si dilata mostruosamente e diviene universalmente accessibile. Il che ˗ unitamente al crollo dei costi di memorizzazione ˗ fa sì che l’antico equilibrio venga sovvertito: ricordare ˗ oggi ˗ diventa la norma, dimenticare l’eccezione.
Tutto bene? Non proprio. Ricordare, ammonisce Schönberger, può costituire anche una maledizione: il protagonista di un racconto di Jorge Luis Borges (“Funes. O della memoria”), ricordando ogni istante della propria vita, vive in uno stato di totale passività, immerso in un flusso mnemonico che ne inibisce il desiderio di agire.
Né meno grave, secondo Schönberger, è la leggerezza con cui rinunciamo a tutelare la riservatezza dei nostri dati personali, lasciandoci trascinare nell’orgia dello scambio di informazioni con “amici” reclutati sui vari social network, senza riflettere sul fatto che, una volta condivise, le informazioni sfuggono al nostro controllo. La conseguenza più grave di simili atteggiamenti è la perdita di quel diritto non scritto all’oblio che fino a ieri garantiva a ogni essere umano di “ridisegnare” periodicamente la propria identità.
Tanto per rimanere in tema va ricordato che uno studente austriaco ˗ Max Schrems ˗ da qualche anno sta conducendo una battaglia alle politiche sulla protezione dei dati adottate da Facebook. La richiesta di danni di questa class action è poco più che simbolica: 500 euro ad utente, che comunque moltiplicati per i partecipanti ˗ ha sottolineato in questi giorni il Financial Times ˗ potrebbe costare al social network qualcosa come 12,5 milioni di euro…
Le persone evolvono, il carattere matura con l’età, le esperienze inducono a cambiare convinzioni e comportamenti. Ma cosa succede se gli sbagli del passato vengono registrati in una memoria destinata a durare eternamente? Si prospetta un futuro incapace di perdonare perché non può dimenticare. Lo confermano i casi sempre più frequenti di licenziamenti, incarichi negati, carriere rovinate, fidanzamenti e matrimoni sfasciati perché qualcuno ha avuto la pessima idea di pubblicare informazioni “compromettenti” sul proprio blog o sul profilo di un social network.
La soluzione tecnica, secondo Schönberger, ci sarebbe: quella di attribuire una data di scadenza a tutte le informazioni. Quando salviamo un file, potremmo stabilirne la durata, ordinando al software di cancellarlo alla scadenza. Si verificherebbe una sorta di “resurrezione artificiale” dell’oblio che limiterebbe la quantità di informazioni che governi e imprese detengono su cittadini e consumatori. Ma se l’informazione è condivisa fra più soggetti, fissarne una data di scadenza implica una difficile trattativa tra gli interessati…
Questa problematica mi fa ripensare alle poesie mandate giù a memoria con lo stesso disgusto con cui, a quei tempi, mi somministravano, per ogni nonnulla, l’olio di ricino. In quel caso il diritto all’oblio non faceva nemmeno in tempo a materializzarsi ché i versi, le date delle battaglie e i nomi dei fiumi dell’America del Sud, dopo qualche ora, erano già bell’e dimenticati. E la memoria tornava libera di lanciarsi nei più spericolati esercizi creativi suggeriti non dal software dei giorni nostri, ma dalla giovinezza.
Guido Giampietro


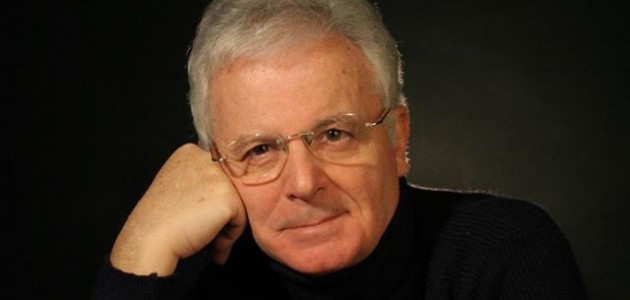
No Comments