Recentemente mi sono imposto una onesta riflessione sul mio morboso attaccamento alle “radici” intese come orgoglio dell’appartenenza alla storia, ai costumi, al linguaggio di questa terra. E perché no? Anche al mare e alla sua grassa e fertile terra. Un orgoglio che m’induce addirittura a credere che qui la natura abbia profuso doni in grande quantità. Mi sono chiesto, in sostanza, se questa mia “fissazione” fosse giusta e, soprattutto, in linea con l’affermarsi di concetti come la globalizzazione e l’integrazione europea.
Sono andato a ripescare un giudizio col quale Raffaele La Capria, anni fa, aveva affrontato la medesima spigolosa questione partendo dalla differenza tra essere napoletani e fare i napoletani. “Essere” napoletani, o milanesi o romani (o brindisini, aggiungo io) ˗ affermava La Capria ˗ significa sentirsi spontaneamente legati al luogo natio in cui ci si è rivelato il mondo, amare i suoi colori e sapori che hanno segnato la nostra infanzia, parlare il suo linguaggio (lo si chiami o no dialetto) indissolubilmente legato alla fisicità delle cose che ci circondano e alla loro musica.
“Fare” i napoletani (o i lombardi), invece, falsifica questa spontanea autenticità in un’artificiosa e pacchiana ideologia. Aver bisogno di farsi fotografare sullo sfondo del Vesuvio o d’inventarsi antenati celti, indossare qualche pittoresco e patetico costume folcloristico serve solo a mascherare l’insicurezza della propria identità.
Ho tirato un sospiro di sollievo. Non sono dunque un integralista delle “radici”, mi sono detto. Il mio pensiero è, tutto sommato, abbastanza vicino a quello dello scrittore napoletano e un po’ distante da quello di Konstantinos Kavafis quando (ne “La città”), a proposito delle radici e dell’impossibilità di liberarsene, afferma: “Non troverai nuove terre, non troverai altri mari. / Questa città ti seguirà. Le strade in cui vagherai saranno / le sue. E crescerai nei suoi quartieri; e ti farai vecchio in queste case…”.
Il mio pensiero procede piuttosto nella stessa direzione di quello di Édouard Glissant discendente di schiavi e oggi uno dei grandi scrittori del mondo. Le radici ˗ ha scritto Glissant ˗ non hanno da sprofondarsi nel buio atavico delle origini, alla ricerca di una pretesa purezza; invece si allargano in superficie, come rami di una pianta, ad incontrare altre radici e a stringerle come mani.
Ergo, fare continui riferimenti alle antichissime e nobili origini di Brindisi, accendere a ogni piè sospinto le luci di una ribalta sulla quale si sono esibiti ˗ in più di due millenni di storia ˗ re, imperatori, papi, grandi condottieri, santi, letterati, capi di Governo, ecc., può finire per essere addirittura controproducente. L’importante è che il rivolo di questa coscienza delle proprie “radici” non vada a finire nello stagno di un vuoto provincialismo, ma sfoci nell’oceano delle altre realtà che ci circondano.
Glissant afferma che ogni identità e il mondo stesso si costruiscono nella relazione, in un processo creativo e armonioso che egli definisce “creolizzazione”, ispirandosi al creolo, la lingua nata dal francese, o meglio, dai dialetti francesi dei padroni di schiavi e dalla parlata di questi ultimi. Essa è divenuta una “lingua franca” dei Caraibi (Glissant è nato nella Martinica), crogiolo e fusione di culture che si incontrano, si mescolano e si trasformano senza perdersi.
Né più né meno a quello che è avvenuto (e tuttora avviene) per tanti scrittori che, per motivi vari, non hanno utilizzato la lingua madre ma quella del Paese che li ha ospitati o nel quale oggi vivono. Così come Italo Svevo, ungherese di origine e italiano in quanto ad aspirazione artistica, o il polacco Joseph Conrad e il russo Vladimir Nabokov che hanno scritto in inglese, o l’irlandese Samuel Beckett che, invece, ha preferito il francese. Ma anche il praghese Milan Kundera, da sempre, scrive in francese, così come l’indiano Salman Rushdie è oramai scrittore anglosassone a tutti gli effetti, e le albanesi Anilda Ibrahimi, Ornella Vorpsi ed Elvira Dones pubblicano le loro opere in italiano…
Loro sì che, anche se nel campo circoscritto della letteratura, hanno superato le ristrettezze mentali delle “radici” e, pur non rinnegandole, le hanno ampliate coinvolgendo la realtà di un mondo più vasto. Dando così ragione a Emil Cioran quando dice: “Non ho nazionalità, e questo è lo status migliore per un intellettuale”.
Ogni identità, dunque, esiste nella relazione. É solo nel rapporto con l’altro che cresco, cambiando senza snaturarmi. Ogni storia rinvia ad un’altra e sfocia in un’altra ancora. Ci sono molte radici. Se una si proclama unica o esclusiva distrugge la vita, sia che si tratti di una radice piccola gelosamente chiusa nella sua particolarità, sia che si tratti di una grande che si atteggia a portatrice di universalità.
Secondo Glissant l’ossessiva difesa, la muraglia, finisce col diventare la prigione dell’identità. Quella cinese è stata costruita non solo per impedire agli invasori di entrare, ma anche per impedire ai cinesi di uscire, come dice quella storia del generale cinese che sorveglia la frontiera e, vedendo un’apertura fra due alte montagne lontane, dice ai suoi Ufficiali: «Là c’è il mondo e noi non ci andiamo». Chiudersi in se stessi è terribile quanto essere conquistati dall’altro o conquistarlo a sua volta. Bisogna assolutamente evitare di arroccarsi nella fortezza de “Il deserto dei Tartari”, aspettando un assalto che non avverrà mai.
La qual cosa significa che non dobbiamo lasciarci andare nemmeno ad una aprioristica chiusura mentale dei confini nazionali nei confronti delle esistenze quasi ancora embrionali e quasi già stroncate di quei derelitti che, alla pari degli schiavi nella stiva delle navi negriere, solcano le acque del Mediterraneo per affacciarsi alla vita e alla storia.
Vivere, dunque, non significa rimanere abbarbicati alle proprie radici e al proprio territorio, ma comporta un migrare. Più che nel senso fisico dello spostamento, in quello mentale. Significa cioè cercare nuovi percorsi, confrontarsi con realtà diverse e, nel caso delle “radici”, abbandonare ogni forma di campanilismo.
Tenendo sempre a mente che ogni identità è una relazione. Una relazione che non s’identifica con una pretesa conoscenza totale dell’altro. Bisogna vivere con l’altro e amarlo, dice Glissant, accettando però anche il rischio di non capirlo a fondo e di non essere capiti a fondo da lui.
Guido Giampietro


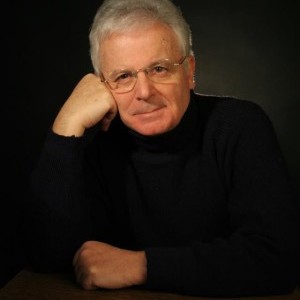
No Comments