 “Semel in anno licet insanire” ̶ una volta all’anno è lecito impazzire ̶ dicevano gli antichi Romani. Ma oggi ha ancora una valenza questo detto? Penso proprio di no. In un mondo che è letteralmente impazzito sarebbe più giusto dire che, almeno una volta all’anno, dovremmo essere saggi e fare cose sensate.
“Semel in anno licet insanire” ̶ una volta all’anno è lecito impazzire ̶ dicevano gli antichi Romani. Ma oggi ha ancora una valenza questo detto? Penso proprio di no. In un mondo che è letteralmente impazzito sarebbe più giusto dire che, almeno una volta all’anno, dovremmo essere saggi e fare cose sensate.
Ma quale era il momento dell’anno in cui si poteva contravvenire alle norme del vivere civile? Non c’è alcun dubbio: il Carnevale, con i suoi costumi allegorici, le maschere e le trombe.
Quel Carnevale che quest’anno, per la Chiesa cattolica, è iniziato il 12 febbraio con la Domenica di Settuagesima, celebrata circa settanta giorni prima della Pasqua, e terminerà il 28 febbraio (martedì grasso). Il giorno dopo, Mercoledì delle ceneri, comincia infatti la Quaresima. Per il rito ambrosiano, invece, la fine del Carnevale è posticipata di quattro giorni.
 Le generazioni dei sessantenni e settantenni sono state le ultime a utilizzare il simbolo per eccellenza del Carnevale: le maschere. Quelle per i bambini, con le effigi dei personaggi delle favole e dei cartoni animati, alle quali bisognava “bucare” occhi e bocca prima di indossarle. E quelle, realizzate con un cartone più spesso e sagomate in modo tale da adattarsi ai volti degli adulti. O le semplici mascherine alla Zorro, necessario complemento dei “domini” che, nelle intenzioni dei più audaci, servivano a mettere in atto gli scherzi più carnascialeschi o le avances più audaci.
Le generazioni dei sessantenni e settantenni sono state le ultime a utilizzare il simbolo per eccellenza del Carnevale: le maschere. Quelle per i bambini, con le effigi dei personaggi delle favole e dei cartoni animati, alle quali bisognava “bucare” occhi e bocca prima di indossarle. E quelle, realizzate con un cartone più spesso e sagomate in modo tale da adattarsi ai volti degli adulti. O le semplici mascherine alla Zorro, necessario complemento dei “domini” che, nelle intenzioni dei più audaci, servivano a mettere in atto gli scherzi più carnascialeschi o le avances più audaci.
Ma le maschere, che affondano la loro origine nel mondo greco-romano, non erano nate solo in funzione del divertimento. In Grecia (VI secolo a.C.) avevano un’origine rituale che si rifaceva al culto di Dioniso, dio dell’estasi e dell’orgia. Avevano cioè un significato di ribellione alle regole, di sregolatezza, di ricerca d’una libertà che, in un’epoca di schiavi e liberti, era spesso negata. In tal modo rappresentavano il mezzo più idoneo per staccarsi dalla realtà, fino a sdoppiarsi e a “vederla” dall’esterno, per commiserarsi e commiserare.
Qualche secolo dopo maschere (e costumi) entrarono nel mondo del teatro assumendo un’importanza fondamentale poiché gli attori interpretavano più personaggi e le figure femminili erano impersonate da uomini. Purtroppo, a causa della fragilità dei materiali con cui erano realizzate (sughero, legno, pelle) non sono giunte fino a noi.
 Invece la scoperta di maschere in terracotta a Lipari o di esemplari scultorei e dipinti nelle case di Pompei ed Ercolano ha permesso di individuarne le principali caratteristiche. Così quelle tragiche visualizzavano gli stati d’animo per mezzo di occhi sbarrati o narici dilatate. Mentre quelle comiche, esasperando le fattezze dei volti, rappresentavano una galleria di personaggi riconducibili alle categorie del genere umano prese di mira nel lavoro teatrale.
Invece la scoperta di maschere in terracotta a Lipari o di esemplari scultorei e dipinti nelle case di Pompei ed Ercolano ha permesso di individuarne le principali caratteristiche. Così quelle tragiche visualizzavano gli stati d’animo per mezzo di occhi sbarrati o narici dilatate. Mentre quelle comiche, esasperando le fattezze dei volti, rappresentavano una galleria di personaggi riconducibili alle categorie del genere umano prese di mira nel lavoro teatrale.
Come le maschere così anche il Carnevale dei giorni nostri (e dell’Ottocento e Novecento) è molto diverso da quello delle origini. Quello pagano si contraddistingueva per l’eccesso di violenza che poteva sfociare in sassaiole (anche con morti), beffe crudeli a discapito di vecchi e donne, oltraggi al comune senso del pudore.
In seguito la natura del Carnevale è cambiata. A cominciare dal XIII secolo quando la Chiesa si preoccupa che, approfittando di ciò che può nascondersi sotto quegli abbigliamenti, possa dilagare una nuova ondata di eresie. Questo timore portò a un incremento di lavoro da parte dei tribunali dell’Inquisizione. E dopo la Riforma subentra addirittura una convergente persecuzione, sia nel mondo cattolico che in quello protestante.
 Nel Settecento furono invece gli stessi feudatari che, per ingraziarsi il popolo e farlo sfogare, chiusero un occhio controllandolo a distanza. Fino a quando, con l’avvento dell’Unità d’Italia e la nascita della borghesia, il Carnevale non viene più visto come una manifestazione necessaria al popolo ma viene trasformato in un genere artistico.
Nel Settecento furono invece gli stessi feudatari che, per ingraziarsi il popolo e farlo sfogare, chiusero un occhio controllandolo a distanza. Fino a quando, con l’avvento dell’Unità d’Italia e la nascita della borghesia, il Carnevale non viene più visto come una manifestazione necessaria al popolo ma viene trasformato in un genere artistico.
Nasceva, o meglio, si riaffermava la Commedia dell’arte, nata già nel Cinquecento ed il teatro diventava un’attività fatta da professionisti. La maschera cambiava di significato e questo contribuisce anche alla fine del Carnevale.
Finisce cioè la voglia di pavoneggiarsi in preziosi costumi di seta confezionati su misura da sarti e sartine. E qui la memoria mi fa rivedere quello d’un principe indiano gelosamente custodito dalla nonna nella cassa del corredo in quanto appartenuto ad un figlio deceduto in un incidente di volo. Ricordo in particolare il turbante sul quale svettava una lunga penna di struzzo e, incastonata, una grossa pietra gialla che si vendicava delle sue umili origini lanciando intorno bagliori dai mille colori. Lo esibii orgoglioso una sola volta ad una festa tenuta nei locali del Circolo Nautico.
Poi tornò a ingiallirsi nella cassa della nonna e il suo ricordo sfumò pian piano insieme all’allegria di quel tempo felice.
Oggi, di quegli stupendi costumi di dame e cavalieri rimane una traccia solo nel carnevale veneziano. Ma, a mio avviso, si tratta d’una esibizione anche troppo sfacciata. È fine a se stessa o forse volta a far ricordare la Serenissima ad un turismo proletario odiato ed amato allo stesso tempo.
 Finiscono le battaglie di coriandoli (ma anche di confetti) e stelle filanti combattute lungo i corsi soprattutto avendo di mira le fanciulle, ben liete d’essere oggetto di quelle attenzioni. In loro vece rimangono le maleducate strisciate degli spray di schiuma che ragazzini invasati peggio di Dioniso distribuiscono a destra e a manca, sotto lo sguardo divertito dei genitori.
Finiscono le battaglie di coriandoli (ma anche di confetti) e stelle filanti combattute lungo i corsi soprattutto avendo di mira le fanciulle, ben liete d’essere oggetto di quelle attenzioni. In loro vece rimangono le maleducate strisciate degli spray di schiuma che ragazzini invasati peggio di Dioniso distribuiscono a destra e a manca, sotto lo sguardo divertito dei genitori.
Sono finiti i veglioni che nei teatri e nelle sale da ballo facevano fare le ore “tarde” agli adulti e consentivano ai giovani, protetti dal travestimento, d’iniziare un dialogo che, in tanti casi, sarebbe continuato per tutta la vita.
E sono anche finite, eccezion fatta per alcune tradizionali piazze, le sfilate di carri allegorici culminanti, qui nel Sud, con il funerale del povero Carnevale che, pure nella sua breve esistenza, tanta allegria aveva regalato a grandi e piccoli.
Rimangono, a testimonianza di un fenomeno tanto importante da essere stato trattato anche dai massimi esponenti della letteratura e dell’arte (Cervantes, Molière, Shakespeare, Goethe, Manzoni, Verga, Gadda, Cézanne, Picasso…), le mascherine che, la domenica, sfidano il freddo esibendosi, felici, per le vie della città.
 Dobbiamo farcene una ragione: il Carnevale, quello sanamente pazzo, è finito! Anche in Brasile l’hanno capito e parecchie città l’hanno cancellato dai trattenimenti per i turisti visto che era diventato imbarazzante giustificare il numero di feriti (e anche di qualche morto) con una esuberanza carnascialesca.
Dobbiamo farcene una ragione: il Carnevale, quello sanamente pazzo, è finito! Anche in Brasile l’hanno capito e parecchie città l’hanno cancellato dai trattenimenti per i turisti visto che era diventato imbarazzante giustificare il numero di feriti (e anche di qualche morto) con una esuberanza carnascialesca.
E le maschere? Anch’esse hanno esaurito il loro compito. O forse no. Perché oramai ognuno di noi ne ha una che indossa tutto l’anno, per tutta la vita. Diceva Pirandello: «Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti».
Guido Giampietro

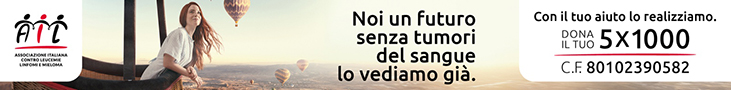



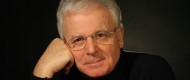



No Comments