 Nel dibattito sviluppato da Maddalena Tulanti sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, e proseguito da Anna Montefalcone, è stata posta con forza la convinzione della Cultura come Bene Comune e di innovazione.
Nel dibattito sviluppato da Maddalena Tulanti sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, e proseguito da Anna Montefalcone, è stata posta con forza la convinzione della Cultura come Bene Comune e di innovazione.
Oggi la sfida è far diventare convenzione sociale e paradigma diffuso quanto e ancora minoritaria convinzione: cioè scelte strategiche con al centro dell’agenda e dell’agire politico la Cultura come sistema strutturato di forme, organizzazioni, creazioni, comunicazione sociale e innovazione.
Così alle parole d’ordine di valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale, di comunità e di internazionalizzazione si deve affiancare la chiave di volta del fare Sistema: tra pubblico e privato, all’interno delle Istituzioni, nei mondi vitali e creativi della comunità.
Capita, operando, che si smarrisca per strada il telos che sottostà alla funzione della Cultura: straordinaria piattaforma di inclusione sociale, creazione di capacità, sviluppo di nuove forme di benessere, cannocchiale per poter intravvedere il futuro.
Chi si occupa di economia della cultura avverte il diffuso fraintendimento di quanti accendono i fari dei media o si scaldano i cuori solo se, a fine serata, si tirano le somme del pubblico pagante (non conoscono la legge di Baumol?) dimenticando di portare all’attivo gli “altri incassi”.
Tre aspetti, tra altri, su cui soffermarsi: fare il sistema Cultura; fare della Cultura il polo dell’innovazione; avere sensibilità al contemporaneo (arte e dintorni).
 1) fare il Sistema: nel funzionamento, coordinamento, connessione nelle Istituzioni e nei rapporti tra di esse e i territori con una comune visione strategica e provare a catturare a nuova “filosofia” il vario mondo del privato. Ambiziosa sfida per superare, e far superare, la concezione del mecenatismo e della sponsorizzazione? Quale può essere il vantaggio per le imprese?
1) fare il Sistema: nel funzionamento, coordinamento, connessione nelle Istituzioni e nei rapporti tra di esse e i territori con una comune visione strategica e provare a catturare a nuova “filosofia” il vario mondo del privato. Ambiziosa sfida per superare, e far superare, la concezione del mecenatismo e della sponsorizzazione? Quale può essere il vantaggio per le imprese?
Intanto la strada della defiscalizzazione può aumentare la massa dei fondi privati alla Cultura. Ma il forte vantaggio dato all’imprese (anche a quelle direttamente operanti nel settore cultura) è dato dalla forza della Cultura di generare valore attivando la coltivazione del gusto, la curiosità e la ricerca esperenziale, il miglioramento e l’efficientamento urbano, facendo accumulare conoscenza e consapevolezza critica, sia individuale che collettiva. In altre parole la Cultura ri-costruisce continuamente l’abito da indossare o costruirsi per stare con gli altri e nei luoghi, oramai flussi relazionali fatti di significazione.
E allora il vantaggio del birrario (di Adam Smith) è dato, oltre che dal continuare a fare buona birra, dal sapere che la sua bottega non sarà in una strada mal ridotta, buia, vuota e insicura, ma ci saranno sempre nuove situazioni che attirano avventori in movimento nella deriva urbana ed esistenziale. I prodotti culturali si vivono e si trasformano in “processi culturali”: questi muovono la realtà.
2) polo dell’innovazione: la tesi di fondo è che lo spostamento verso attività e servizi più innovativi nella sostenibilità (si pensi alle potenzialità del trinomio: turismo, cultura, territorio) dipende soprattutto dalla capacità di costruzione sociale dell’innovazione.
L’economia relazionale è caratterizzata da fattori extra mercato, difficili da governare con semplici relazioni contrattuali, che si basano su condizioni di contesto facilitanti la cooperazione tra soggetti individuali e collettivi. Innovazione e qualità dipendono meno da aziende isolate e maggiormente dalla capacità del contesto, locale – istituzionale – sociale, di offrire un milieu favorevole: la costruzione sociale dell’innovazione offre beni collettivi di cui i singoli attori hanno più bisogno, ma che non sono in grado di produrre da soli.
Anche per questo l’innovazione funziona, e ha funzionato in casi anche meridionali, in situazioni di sviluppo locale partecipato, sostenibile e nei quali la comunità si è auto organizzata. Ciò ha favorito la cooperazione tra i vari attori sociali nel migliorare il territorio, ridurre i dualismi ed i conflitti, affrontare la sfida dell’innovazione dei processi sociali avanzati. Tutto ciò è anche il tentativo di dar forma razionale ai processi democratici e di inclusione.
3) sensibilità al contemporaneo. Esso si presenta sotto forme diverse, con significati spesso massificanti. Purtuttavia sotto il segno dei fattori culturali più eterogenei vivono, e si manifestano, espressioni e modalità che a pieno titolo possiamo catalogare come momenti significanti la riflessione critica sul presente.
Ciò accade, non sempre, sia nelle arti visive che in quelle performative, come anche in manifestazioni di qualificazione territoriale non peculiarmente folcloriche. Il tema è: può stabilirsi un diverso equilibrio, e relativo peso specifico, tra le risorse culturali storicamente intese come patrimonio e le novità formali, linguistiche e produttive delle cosiddette creazioni del contemporaneo?
Si può pensare che anche la novità del contesto passi da un diverso diritto di cittadinanza, nella sfera dei significati sociali e diffusi, di ciò che appare “ricercato e non immediatamente percepito dai più”?
Mi riferisco non solo a forme di sperimentazione ma alle modalità, diffuse e strutturate in contesti anche italiani, di arte pubblica, di arte ambientale, di educazione a scoprire significati e evocazioni meno immediate, più complesse e articolate.
E’ errato, in proposito, valutare solo la capacità di offerta per un dato livello di domanda, come si fa per qualsiasi prodotto commerciale.
Nel nostro caso è tipicamente l’offerta a creare la propria domanda e l’articolazione territoriale di questo sistema diviene la premessa per poter creare progressivamente un pubblico, come nell’esperienza dei paesi nordici le cui reti del contemporaneo sono distribuite più capillarmente che da noi.
Capire e soprattutto sentire che senza una solida rete del contemporaneo anche la nostra tanto decantata eredità culturale ci diventa estranea, al pari della misera quanto oggi popolare metafora del petrolio d’Italia.
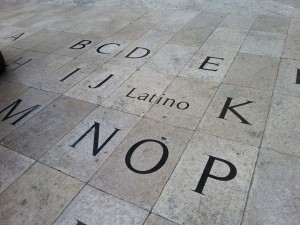 Altre questioni sono sopra e sotto il tappeto da spazzare e preservare con la “politica della Cultura” della Regione, dei Comuni, di tutte le istituzioni e infrastrutture del territorio.
Altre questioni sono sopra e sotto il tappeto da spazzare e preservare con la “politica della Cultura” della Regione, dei Comuni, di tutte le istituzioni e infrastrutture del territorio.
Coinvolgere i corpi sociali e quanti lavorano nella creazione di significati deve essere la modalità implementativa e quotidiana dell’azione pubblica.
L’imperativo, valido per tutti, è fare società.
Modi, sistemi di valutazione, confronti e prove d’arte devono essere continuamente rivisitati criticamente: produrre Cultura a mezzo di Cultura.
Emanuele Amoruso


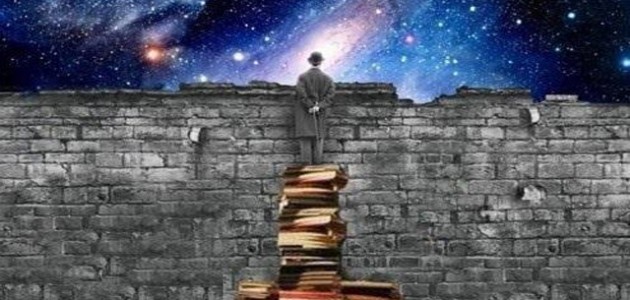
No Comments