 “… Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d’Egitto. Il faraone non vi ascolterà e io porrò la mano contro l’Egitto con grandi castighi… (Esodo, 7, 4-5).
“… Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d’Egitto. Il faraone non vi ascolterà e io porrò la mano contro l’Egitto con grandi castighi… (Esodo, 7, 4-5).
E vennero le dieci piaghe… L’invasione di rane, zanzare, mosche, cavallette… E, ancora, la moria del bestiame, le ulcere, la pioggia di fuoco e ghiaccio, le tenebre… L’ira del Signore fu tremenda ma, stranamente, non colpì le piante. E se, a distanza di migliaia di anni, il flagello della xylella fastidiosa (perniciosa, direi) fosse un continuum? Se il Signore avesse deciso d’infliggere l’undicesima piaga perché c’è gente (come Kim Jong-un e Trump) che gioca a distruggere il “suo” mondo?
Potrebbe essere questa la chiave di lettura non scientifica di un fenomeno che sta uccidendo tutti gli ulivi del Salento? I nostri… i miei ulivi.
Forse il lettore si stupirà nel venire a conoscenza che chi scrive, pur non essendo censito al catasto agricolo, sia proprietario di migliaia di ettari di terreno coltivato a uliveto. Il che significa, in altri termini, il possesso di tutti gli ulivi della Puglia. Naturalmente, a scanso di equivoci, mi affretto a precisare che si tratta di un possesso sentimentale.

Infatti gli ulivi li considero miei in virtù di una successione testamentaria da parte degli antenati spartani che, giungendo su questa terra – la futura Magna Grecia – per primi li piantarono.
Lo sono perché nei miei occhi, da sempre, insieme al brillio del sole e al blu del mare si rispecchia il verde argentato delle loro chiome.
Così come miei sono i millenari frantoi ipogei che nella frescura delle caverne hanno trasformato il nero frutto nel biondo oro di un olio che non ha eguali al mondo.
E perché, quando oltrepasso i confini della Regione, è la nostalgia della loro lontananza a farmi desiderare di rientrarvi al più presto.
Sono quindi perfettamente d’accordo con Indro Montanelli quando diceva: “Ogni filare di viti o di ulivi è la biografia di un nonno o bisnonno”. O quando Tucidide, lo storico ateniese, già intorno al 400 a.C. affermava: “I popoli del Mediterraneo uscirono dalla barbarie quando impararono a coltivare l’ulivo e la vite”. Io, nel mio piccolo, dico che la linfa degli ulivi scorre nel nostro sangue, anche se dall’analisi dell’emocromo non compare.
E ora questa ricchezza incalcolabile viene distrutta da un batterio veicolato da insetti vettori che l’acquisiscono con l’apparato boccale di tipo “pungente – succhiante” (la cosiddetta sputacchina) trasferendolo alle piante sane, siano esse spontanee oppure coltivate.
Un fenomeno che, manifestatosi dapprima nel basso Salento a partire dal 2008-2010, è stato definito da Joseph-Marie Bovè, dell’Académie d’agricolture de France, come “la peggiore emergenza fitosanitaria al mondo”.
Un fenomeno sottovalutato dapprima da una parte degli stessi agricoltori che purtroppo, per una disaffezione alla coltura dei campi o per il loro completo abbandono in cambio della chimera industriale, hanno omesso di praticare la tecnica (certamente faticosa) dell’aratura. Un’azione che avrebbe avuto un notevole effetto di contenimento e prevenzione dello sviluppo futuro delle piante infestanti, rallentandone la diffusione e consentendo di trovare nel frattempo la soluzione per la cessazione dell’epidemia.

Ma è un fenomeno sottovalutato anche dai politici, quelli nostrani e quelli di Bruxelles. Sono dell’aprile del 2015 (ahimè, un tempo colpevolmente lungo) le parole di Loredana Capone, all’epoca assessora allo Sviluppo economico della Regione Puglia, “ora più che mai dobbiamo essere uniti. Tutti, dalla Commissione Europea alla Provincia, a tutta la nostra Regione, dobbiamo concorrere nella ricerca con progetti che accelerino gli studi… Non possiamo più aspettare: dobbiamo sostenere i nostri agricoltori e dobbiamo salvare i nostri ulivi che raccontano generazioni di amore, passione, cura, dedizione…”.
E Rocco Palese, deputato di Forza Italia, sempre nel 2015, auspicando di lasciare da parte le polemiche e i rimpalli di responsabilità, aveva lanciato un appello al presidente Mattarella perché fosse emanata una legge speciale, così come fatto per la Terra dei fuochi, in quanto “unica strada da seguire in questo momento”.
E dopo? A parte le “grida” di Bruxelles (punitive più che propositive) e il piano (contestato) del commissario Silletti finalizzato all’estirpazione delle piante nella zona infetta, più nulla di serio da parte della politica. Anche in questi giorni in cui nelle nostre province si assiste alla “transumanza” di gente come D’Alema e Salvini, di tutto si sente parlare fuorché del problema xylella.
E, per completare il desolante quadro, c’è da prendere atto che anche la ricerca (in particolare quella condotta dall’Università di Bari) procede con la lentezza propria degli studi scientifici. Nessun convegno internazionale è stato organizzato. Nessuna “eureka” si è ascoltata, nemmeno sottovoce, tra gli addetti ai lavori. Segno che ancora si naviga al buio.
 In compenso, a parlarne (e a pubblicizzare il caso nel mondo internazionale dello spettacolo e del jet set) è una straniera: Helen Mirren, la “contadina salentina”, premio Oscar per il film “The Queen”. Da tempo trapiantata nel Salento ha preso a cuore il problema della xylella. E giorni fa, insieme ad agricoltori e tecnici, si è recata a Strudà, un paesino del leccese, in località Masseria Visciglito, per rendersi conto della riuscita degli innesti di alcuni resistenti effettuati a giugno per proteggere uno degli ulivi monumentali più antichi al mondo, la “Regina”, dedicata all’ex First Lady Michele Obama.
In compenso, a parlarne (e a pubblicizzare il caso nel mondo internazionale dello spettacolo e del jet set) è una straniera: Helen Mirren, la “contadina salentina”, premio Oscar per il film “The Queen”. Da tempo trapiantata nel Salento ha preso a cuore il problema della xylella. E giorni fa, insieme ad agricoltori e tecnici, si è recata a Strudà, un paesino del leccese, in località Masseria Visciglito, per rendersi conto della riuscita degli innesti di alcuni resistenti effettuati a giugno per proteggere uno degli ulivi monumentali più antichi al mondo, la “Regina”, dedicata all’ex First Lady Michele Obama.
Nel frattempo la xylella ha camminato. Ha tanto camminato da giungere già nel nord brindisino (focolai accertati a Cisternino e Ostuni). Da qui la decisione della Regione di abbattere con le ruspe, oltre agli alberi malati, anche quelli sani che rientrano nel raggio di cento metri dagli ulivi infetti. Ad essere per il momento salvati sono solo quelli “monumentali” presenti nei cento metri, che andranno però isolati attraverso un sistema di copertura indicato dalla stessa Regione. I proprietari avranno venti giorni di tempo (dalla notifica dei provvedimenti di eradicazione) per estirpare le piante.
Mi chiedo se sia giusto che le cose siano andate, stiano andando in questo modo. Se non si sarebbe dovuto evitare che la xylella proseguisse indisturbata il suo malefico incedere.

E ora che cosa ci attende? Si dovranno distruggere anche gli ulivi delle Murge e, via via, tutti gli altri fino a giungere a quelli della piana bitontina e oltre?
Cosa avverrà del paesaggio pugliese? Quello “catturato” da pittori e fotografi di mezza Europa. E quello descritto in letteratura. E quali saranno le conseguenze sull’economia pugliese (ma anche nazionale) che, fino ad oggi, dagli ulivi ha tratto il maggiore sostentamento? Ho paura a darmi una risposta. Allora vorrei che a parlare fossero le Istituzioni, i ricercatori, gli agronomi, i vecchi contadini. Ma da quella parte mi arrivano solo voci del tipo: eradicare, trinciare, pirodiserbare…
A questo punto l’unica, amara considerazione è che, ancora peggio del dramma della perdita degli ulivi, sia l’indifferenza. E per debellare questa, ahimè, non sarebbe efficace nemmeno una dodicesima piaga!
Guido Giampietro

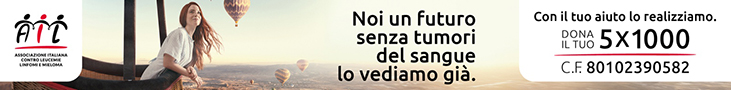




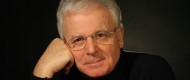


No Comments