 In un mondo che, malgrado le bugiarde assicurazioni degli addetti ai lavori, continua a soffrire di un default oramai cronicizzato, le proposte per uscire dalla crisi che ha travolto governi e debiti sovrani sono sempre all’ordine del giorno.
In un mondo che, malgrado le bugiarde assicurazioni degli addetti ai lavori, continua a soffrire di un default oramai cronicizzato, le proposte per uscire dalla crisi che ha travolto governi e debiti sovrani sono sempre all’ordine del giorno.
Lasciando ai bocconiani le discussioni sull’attualità e/o l’applicabilità delle teorie economiche keynesiane mi limito a riportare i casi di alcuni Paesi che, per ripianare i debiti, hanno preso in considerazione la vendita di una parte del proprio patrimonio culturale.
È stata per prima la Finlandia che, un paio di anni fa, ha pensato a una soluzione del genere per prendere le distanze da un eventuale default della Grecia. Infatti, di fronte alla richiesta di rifinanziare Atene, Helsinki lanciò la proposta di chiedere a garanzia il Partenone per un importo equivalente a 300 miliardi di euro.
Il suggerimento, giudicato alla stregua di una boutade, non ebbe seguito ed il Partenone non rischiò la stessa fine dei suoi fregi esposti al British Museum di Londra (15 metope, 56 bassorilievi di marmo, 12 statue, quasi l’intero frontone ovest, una Cariatide del tempietto dell’Eretteo…).
Tanto per intenderci quei fregi trafugati da Lord Elgin e mai restituiti ai legittimi proprietari!
Più recenti gli altri due casi.
Il primo si è verificato a Detroit, la capitale americana dell’auto che, sotto il peso di debiti per 18 miliardi di dollari, ha tentato di cedere i capolavori della collezione del DIA, il Detroit Institute of Arts.
I creditori hanno fatto fare una perizia sulla collezione che comprende capolavori di Caravaggio, Tiziano, Rembrandt, Van Gogh, Rubens, Matisse, Cézanne e Degas… L’importo complessivo di questa svendita sarebbe stato di circa 2,5 miliardi di dollari, ma anche qui ˗ grazie all’intervento di fondazioni e di privati ˗ il progetto non è andato a buon fine.
Il secondo caso ha riguardato il Portogallo che, insieme a Grecia ed Irlanda, più risente in Europa della crisi economica.
Sotto la pressione di un piano di salvataggio di quasi 80 miliardi di euro ha cercato di privatizzare una raccolta di 85 Mirò.
Anche qui l’asta delle opere, provenienti dalla collezione del fallito Bpn ˗ banca salvata dallo Stato nel 2008 ˗ è stata cancellata dalla stessa casa d’aste Christie’s di fronte alle proteste dei nazionalisti e degli intellettuali ed al rischio di eventuali strascichi internazionali.
![Patrimonio-artistico-Italiano[1]](http://www.brundisium.net/brun/wp-content/uploads/2014/03/Patrimonio-artistico-Italiano1-300x300.jpg) In questo filone s’inserisce, per ultima, la nostra Corte dei Conti che, qualche settimana fa, ha contestato all’agenzia di rating Standard & Poor’s il declassamento nel 2011 dell’Italia senza pensare minimamente all’immenso patrimonio artistico e culturale di cui il Paese dispone.
In questo filone s’inserisce, per ultima, la nostra Corte dei Conti che, qualche settimana fa, ha contestato all’agenzia di rating Standard & Poor’s il declassamento nel 2011 dell’Italia senza pensare minimamente all’immenso patrimonio artistico e culturale di cui il Paese dispone.
L’ipotesi di richiesta danni è stata quantificata in 351 miliardi: 117 per le manovre obbligate dal declassamento e 234 per il danno d’immagine. Va però detto che già nei giorni successivi alla richiesta la stessa Corte ha assunto un atteggiamento più prudente e meno scontato.
Secondo Stefano Baia Curioni, vicepresidente del Centro di ricerca Ask (Art, science and knowledge) della Università Bocconi, questi tentativi altro non sono che “provocazioni”.
E queste provocazioni, a suo giudizio, possono avere due valori: «Aprire un dibattito sulla valutazione della riserva culturale implicita di un Paese, sul modo in cui vengono valutati gli Stati e la loro solvibilità; spiegare la natura del patrimonio, spesso considerato solo come bene economico mentre il suo rapporto con lo sviluppo passa dalla capacità di contribuire a formare capitale sociale, cioè la comunità politica di un Paese».
Ecco dunque la differenza di cui bisogna tenere conto: quella tra capitale economico e capitale sociale (o patrimonio culturale). E se è vero che rispetto al primo l’Italia ha endemici problemi di consistenza, è altrettanto evidente come con l’altro sussista una innegabile situazione di sovrabbondanza! Tanto da far venire, non solo al comune cittadino ma addirittura alla Corte dei Conti, l’idea di fare cassa vendendo un’infinitesima parte dei beni culturali disseminati lungo tutto il Bel Paese, a cominciare da quelli ammassati nei polverosi depositi di musei piccoli e grandi.
L’idea ˗ classico uovo di Colombo ˗ apre le menti su scenari vagheggiati solo nei sogni.
![20131207141236-2013-86612-NDP[1]](http://www.brundisium.net/brun/wp-content/uploads/2014/03/20131207141236-2013-86612-NDP1-300x200.jpg) L’Italia abbatterebbe in un amen il suo spaventoso debito pubblico e, come per incanto, salirebbe al primo posto della graduatoria dei Paesi più virtuosi se… Se però, a svegliarci da questo sogno, non ci fosse la Costituzione! Già! Perché, nei Principi fondamentali, l’articolo 9 della Costituzione così recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Vale a dire che i Costituenti hanno scelto di assumere tra i compiti essenziali dello Stato la promozione e lo sviluppo culturale della collettività.
L’Italia abbatterebbe in un amen il suo spaventoso debito pubblico e, come per incanto, salirebbe al primo posto della graduatoria dei Paesi più virtuosi se… Se però, a svegliarci da questo sogno, non ci fosse la Costituzione! Già! Perché, nei Principi fondamentali, l’articolo 9 della Costituzione così recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Vale a dire che i Costituenti hanno scelto di assumere tra i compiti essenziali dello Stato la promozione e lo sviluppo culturale della collettività.
Al di fuori e al di là di valutazioni meramente patrimoniali s’inserisce dunque la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.
E che l’articolo 9 sia una conferma della bontà della nostra carta costituzionale lo dimostra il fatto che è stato integralmente copiato da quelle portoghese e maltese e parafrasato da alcuni Paesi del Sud America.
Per meglio comprendere la differenza esistente in materia normativa tra noi e gli altri basti pensare che negli Stati Uniti non c’è nemmeno il ministero dei Beni culturali! In pratica il patrimonio soggetto a tutela si limita ai parchi pubblici… E non potrebbe essere diversamente visto che non esistono né siti archeologici né immobili che trasudano storia, e che le più rinomate collezioni d’arte si sono alimentate con i trasferimenti ˗ più o meno legittimi ˗ di opere provenienti soprattutto dall’Europa (Grecia e Italia in testa).
Dunque il nostro patrimonio culturale è costituzionalmente tutelato e in gran parte inalienabile. Proprio per questa sua natura si tratta di un patrimonio “sociale” e non commerciabile. A voler essere più precisi sono inalienabili i beni archeologici, i monumenti nazionali, le raccolte dei musei, gli archivi; sono alienabili previa autorizzazione i beni come gli immobili vincolati; e infine alienabili solo quei beni che, per vari motivi, hanno perso l’originale carattere culturale.
 Senza nulla togliere al valore dell’articolo 9 della Costituzione viene spontanea la domanda se, nella situazione di estremo degrado in cui versano i beni culturali in Italia (tra questi includo anche il nostro caro Castello Alfonsino…), non sia il caso di aprire una porticina, se non proprio all’alienabilità, quanto meno ad una loro oculata privatizzazione, anziché assistere, impotenti, ad una inevitabile, lenta agonia. Insomma, se non sia il caso di trovare il giusto equilibrio tra chi punta a privatizzare con arroganza tutto e chi invece individua nella mano privata il Male Assoluto.
Senza nulla togliere al valore dell’articolo 9 della Costituzione viene spontanea la domanda se, nella situazione di estremo degrado in cui versano i beni culturali in Italia (tra questi includo anche il nostro caro Castello Alfonsino…), non sia il caso di aprire una porticina, se non proprio all’alienabilità, quanto meno ad una loro oculata privatizzazione, anziché assistere, impotenti, ad una inevitabile, lenta agonia. Insomma, se non sia il caso di trovare il giusto equilibrio tra chi punta a privatizzare con arroganza tutto e chi invece individua nella mano privata il Male Assoluto.
Quella del bilanciamento tra pubblico e privato appare dunque la via più corretta da percorrere.
Non certo nell’illusione di conseguire una sensibile riduzione del debito pubblico, ma nella convinzione che il rispetto e la cura dovuti al nostro patrimonio culturale potrebbero apportare, grazie anche all’intervento di fondazioni e privati, concreti benefici al Paese.
Guido Giampietro

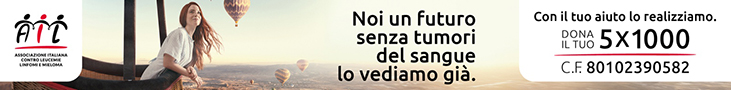




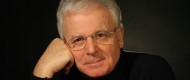



No Comments