![china-india-e1340983817767[1]](http://www.brundisium.net/brun/wp-content/uploads/2014/04/china-india-e13409838177671-300x188.jpg) Il grande giornalista Luigi Barzini, il 12 luglio 1900, a bordo del piroscafo “Prinz Heinrich” diretto in India e Cina scriveva: «La civiltà è una cosa bellissima, ma monotona. La sua luce possente rende le cose del medesimo colore. I paesi più lontani diventano eguali; a poco a poco le differenze di costumi, di uso, perfino di linguaggio e di razze vanno scomparendo. Tutto quanto c’è di più incantevole, la varietà si appiana. Il mondo finirà per non presentare più attrattive di una palla di biliardo».
Il grande giornalista Luigi Barzini, il 12 luglio 1900, a bordo del piroscafo “Prinz Heinrich” diretto in India e Cina scriveva: «La civiltà è una cosa bellissima, ma monotona. La sua luce possente rende le cose del medesimo colore. I paesi più lontani diventano eguali; a poco a poco le differenze di costumi, di uso, perfino di linguaggio e di razze vanno scomparendo. Tutto quanto c’è di più incantevole, la varietà si appiana. Il mondo finirà per non presentare più attrattive di una palla di biliardo».
All’epoca Barzini parlava di civiltà; il termine globalizzazione non era stato ancora inventato. A voler essere pignoli, adeguando il suo pensiero al nostro, potremmo dire che oggi il mondo presenta, al posto della superficie levigata di una boccia da biliardo, le fossette di una zigrinata pallina da golf.
In effetti la civiltà-globalizzazione ha fatto (purtroppo, in alcuni casi!) dei passi, ma non quelli di gigante che ipotizzava l’inviato del Corriere. Gli jeans stracciati che si vedono da noi, sono gli stessi esposti nelle vetrine della Quinta Avenue, a loro volta eguali a quelli indossati dai miserabili delle favelas.
In quanto al linguaggio l’inglese sta lentamente soffocando le parlate più antiche ed espressive. Lo stesso Griko del Salento è a rischio estinzione.
La cucina poi, internazionalizzandosi, perde a poco a poco i connotati dei sapori e dei colori locali dovuti alla mescolanza di spezie e frutti coltivati in orti lontani migliaia di chilometri.
La musica, sempre più globalizzata, rischia di sopraffare la libertà del canto. Quella libertà che deve consentire al beduino di continuare a cantare al deserto le storie millenarie del suo popolo. Così come devono poter fare la geisha o il santone indù o la ragazza armena che percorre i sentieri dell’antica Anatolia.
![bandiera-europa[1]](http://www.brundisium.net/brun/wp-content/uploads/2014/04/bandiera-europa1-300x216.jpg) Si stanno standardizzando le stesse usanze di come festeggiare l’arrivo al mondo di un bambino e come salutare l’uscita dalla vita, se piangendo o con la riconoscenza di chi sa d’avere avuto tanto.
Si stanno standardizzando le stesse usanze di come festeggiare l’arrivo al mondo di un bambino e come salutare l’uscita dalla vita, se piangendo o con la riconoscenza di chi sa d’avere avuto tanto.
Perfino gli armamenti, gestiti oramai dalle grandi multinazionali, si ritrovano ˗ identici ˗ presso gli eserciti delle Potenze mondiali e presso le armate Brancaleone degli staterelli africani.
Fortunatamente, però, l’incubo di un mondo uniformemente grigio e “totalmente amministrato”, come dicevano i filosofi della Scuola di Francoforte, sembra essersi un po’ attenuato. La modernità, con la sua razionalizzazione unificante tesa a livellare le differenze (salvo quelle economiche tra ricchi e poveri!) in un sistema uguale per tutti, sta segnando il passo…
Come afferma Claudio Magris, si può dire che la globalizzazione-omogeneizzazione «si sia capovolta nel suo contrario… in una miriade di microcosmi sempre più piccoli e particolari che si suddividono in unità sempre più piccole e particolari, riluttanti a riconoscersi parti di una totalità che le comprende e reclamanti ciascuna la propria diversità (nazionale, culturale, etnica, sessuale, politica, giuridica)».
I casi delle secessioni del Kosovo, della Crimea e quelle in calendario della Scozia e della Catalogna ˗ per non parlare del patetico tentativo indipendentista di un Veneto che aspira a ritornare sotto il vessillo di una rediviva Serenissima ˗ altro non sono che testimonianze di una volontà (in questo caso politica) di non riconoscersi (più) quali parti di un insieme più grande, oltre che storicamente ed internazionalmente riconosciuto.
«Alla geometria del Moderno ˗ continua Magris ˗ è subentrato un Medioevo globale, frazionato, atomistico, come ai tempi del Sacro Romano Impero, in cui per ogni luogo, per ogni corporazione, per ogni comunità e realtà politica e amministrativa si sovrapponevano intrecciandosi e aggrovigliandosi, leggi, prerogative e obblighi diversi».
![la-legge-c3a8-uguale-per-tutti1[1]](http://www.brundisium.net/brun/wp-content/uploads/2014/04/la-legge-c3a8-uguale-per-tutti11-300x201.jpg) Dunque è specialmente nel campo del diritto che la globalizzazione apporta un’inversione nel trend dell’uniformità, dell’appiattimento. La stessa frase “La legge è uguale per tutti”, bene in vista in tutte le aule giudiziarie, comincia ad essere poco credibile. Intanto per il modo in cui è gestita la giustizia, formalmente fedele ai codici di procedura, ma talvolta in stridente contrasto con i principi del diritto universale e, soprattutto, della morale. A ragione diceva Solone: «Le leggi scritte non differiscono in nulla dalle tele di ragno perché trattengono i deboli e i piccoli mentre si lasciano lacerare dai potenti e dai ricchi…».
Dunque è specialmente nel campo del diritto che la globalizzazione apporta un’inversione nel trend dell’uniformità, dell’appiattimento. La stessa frase “La legge è uguale per tutti”, bene in vista in tutte le aule giudiziarie, comincia ad essere poco credibile. Intanto per il modo in cui è gestita la giustizia, formalmente fedele ai codici di procedura, ma talvolta in stridente contrasto con i principi del diritto universale e, soprattutto, della morale. A ragione diceva Solone: «Le leggi scritte non differiscono in nulla dalle tele di ragno perché trattengono i deboli e i piccoli mentre si lasciano lacerare dai potenti e dai ricchi…».
Proprio per tutelare l’uguaglianza si sono adottate misure diseguali come le tanto chiacchierate quote rosa, i punteggi a favore dei disabili, dei terremotati, dei profughi, e così via. Misure che devono peraltro cessare quando cessano le situazioni che le hanno richieste e questo per non creare nuove ed opposte ingiustizie.
Insomma sembra proprio che il “vecchio buon diritto” delle Corporazioni medievali abbia preso il sopravvento su quello moderno, figlio della Rivoluzione francese. Oggi si rischia di non avere più una legge uguale per tutti perché ci sono tante leggi, leggine e regolamenti che vengono incontro alle esigenze particolari di fasce della popolazione reclamanti la loro peculiarità e norme adatte alla loro diversità.
Va ricordato il caso di alcuni genitori musulmani che, tempo fa, hanno chiesto, per i loro figli, classi differenziate nell’ambito della scuola pubblica, ritenendo che per cultura e religione non potessero mescolarsi con ragazzi di altre etnie…
E dal momento che è tuttora in corso il dibattito parlamentare sulla nuova legge elettorale non è da escludere che tra le centinaia di emendamenti non spunti quello che voglia diversificare il “peso” del voto. Infatti, siccome il problema del giorno è principalmente quello del futuro dei giovani, si potrebbe pensare di dare più peso al voto di questi rispetto a quello degli anziani. E, tra i giovani, si potrebbero creare ulteriori differenziazioni di “peso” a seconda della fascia d’età…
Insomma, se si intraprendesse questa strada, le rivendicazioni di libertà particolari finirebbero per dimenticare il fondamento del liberalismo e della democrazia, secondo il quale la mia libertà cessa dove inizia quella di un altro.
Un po’ quello che Voltaire aveva sintetizzato con la frase: «Non approvo quello che dite ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo».
C’è dunque da augurarsi che la globalizzazione, nefasta per l’appiattimento di costumi e perfino coscienze, riesca invece a preservare dalle diversità (etniche, sessuali, religiose) il principio che “la legge è uguale per tutti”.
Una certezza di cui, in questo momento storico, abbiamo particolarmente bisogno.
Guido Giampietro

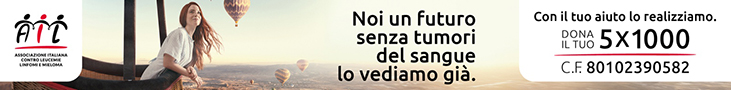



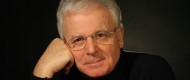



No Comments