Qualche giorno fa, senza rendercene conto, abbiamo sfiorato una Quarta guerra d’indipendenza (o la Quinta se consideriamo quarta la Prima guerra mondiale). Insomma poco è mancato che, per fronteggiare al Brennero l’esercito austriaco, non mandassimo ancora una volta a morire sul Carso e lungo il Piave i nostri soldati.
E meno male che l’Austria questa volta ci ha graziati. Non per timore della nostra reazione militare, ma per quello più grave delle (eventuali) sanzioni pecuniarie dell’Europa.
Così, venuta meno l’opzione militare, per cercare di risolvere il problema dell’ondata migratoria all’Italia rimane, come extrema ratio, quella della minaccia: chiudere i porti alle navi Ong che trasportano illegalmente gli illegali emigranti. Senza tenere però presente che la chiusura dei porti non si è mai rivelata una mossa vincente.
Per esempio, a Brindisi, fin dai tempi della Roma repubblicana, nell’anno 49 a.C., Cesare, per bloccare la fuga di Pompeo verso la Grecia, aveva sbarrato il porto facendo costruire, all’altezza del canale Pigonati, una diga in terra e pietre e, successivamente, ricorrendo all’affossamento di zattere e al conficcamento sul fondale di lunghi pali. Ma il tentativo fallì e Pompeo, di notte, riuscì a fuggire con i suoi soldati.
Sempre a Brindisi, nel 1279, ci riprovò Carlo I d’Angiò, ponendo sul canale d’entrata al porto interno una catena di ferro che veniva tesa tra due torri durante la notte e ritirata sotto una tettoia durante il giorno. Anche questa volta, i risultati furono scarsi.
Infine il principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini Del Balzo, che signoreggiava su Brindisi, preoccupato della potenza dei Veneziani, nel 1449 attuò un malaugurato stratagemma: fece affondare un bastimento carico di pietre, otturando il canale e consentendo così il passaggio solo alle piccole barche. La qualcosa rese per decenni impraticabile il porto, oltre ad essere causa di una malaria tanto nefasta per la città.
Allora, visto che la Storia è magistra vitae, oggi questa minaccia appare inattuabile. Per di più, a mettere un bel macigno sulla questione, è intervenuta la decisione presa in occasione del vertice dei ministri dell’Interno tenuto a Tallinn il 6 luglio scorso, secondo la quale la «regionalizzazione» degli sbarchi verso altri partner mediterranei «non era all’ordine del giorno». Il che, in parole povere, vuol dire l’Europa è contraria all’apertura di altri porti dell’Unione per accogliere i migranti salvati in mare. Amen!
Che cosa si può dunque fare, o meglio, che cosa deve fare l’Europa per regolamentare questa tragedia epocale dell’emigrazione?
Certamente è troppa poca cosa l’accettazione delle altre proposte (avanzate dal ministro dell’Interno Marco Minniti) che vanno dagli aiuti economici alla Libia al codice di regolamentazione per le Ong impegnate nel soccorso in mare, all’implementazione della politica dei rimpatri con la concessione di pacchetti di visti ai Paesi che si riprendono gli immigrati irregolari.
Purtroppo c’è da prendere atto che l’Europa è oramai diventata qualcosa d’imbarazzante. È un coacervo di egoismi nazionali che dura finché questi non vengono disturbati.
Ci saremmo aspettati da Minniti un discorso di questo tipo: «Cari signori, l’Italia non sopporta più di vedere annegare migliaia di persone nel mare che non è solo “nostrum”, ma è anche vostro. Quindi faremo di tutto per salvare il maggior numero possibile di migranti. Ma questo costa. E siccome le risorse di cui disponiamo non riescono a soddisfare nemmeno le esigenze della nostra gente, sappiate che se continuerete a cincischiare, alle prossime scadenze l’Italia si vedrà costretta a sospendere qualsiasi tipo di finanziamento, compreso quello ordinario».
E invece Minniti cosa ha fatto? Si è limitato a lanciare un appello ai colleghi dei 27 Paesi (c’era anche il Regno Unito) richiamandoli al senso di responsabilità piuttosto che minacciandoli seppure velatamente. «Non lasciate che il ministro dell’Interno italiano rimanga da solo perché, se l’Italia viene lasciata sola, potrebbe essere costretta a procedere da sola. Io non voglio, ma non posso escluderlo… questo però dipende dalle decisioni che prenderemo insieme». Questo ha detto Minniti e quelli sono sbiancati per la paura!
Insomma in Estonia l’Italia, tanto per cambiare, ha scelto la politica del “passo dopo passo”, con l’obiettivo di “non rompere per non rimanere isolata”. Figurarsi se, in quel contesto, c’erano le condizioni per gettare sul tappeto la possibilità estrema di una “Italexit”. Sì, avete compreso bene: proprio una uscita dell’Italia dall’Europa! Tanto, peggio di così non si può andare, viste le misure penalizzanti per il nostro Paese soprattutto in materia di agricoltura, pesca, sistema bancario, sfacciati favoritismi alle multinazionali, e via dicendo.
Ortega Y Gasset, nel discorso “Meditazione sull’Europa” pronunciato a Berlino nel 1949, diceva: «L’uomo europeo è vissuto sempre, nello stesso tempo, in due spazi storici, in due società, una meno densa ma più ampia, l’Europa, un’altra più densa ma territorialmente più ridotta, cioè l’area di ogni nazione. E’ quindi un errore pensare che l’Europa sia una figura utopistica che forse nel futuro si riuscirà a realizzare? No: l’Europa non è soltanto futuro ma anche qualcosa che è lì già da un passato remoto, e per di più l’Europa esiste prima delle nazioni. Lungi dall’essere l’unità europea un mero programma politico per l’immediato avvenire, è l’unico principio per capire l’Occidente».
Con tutto il rispetto che nutro per questo filosofo e saggista non sono d’accordo con la sua idea di Europa. Dico di più: non sono d’accordo con quello che l’Europa è nel frattempo divenuta: una Unione semplicemente economica e per nulla politica. Allora, se le cose non cambiano, c’è solo da uscirne fuori, come ha fatto coraggiosamente l’Inghilterra.
Questo significa essere non europeisti? Certamente sì se continuiamo a seguire il solco tracciato dai nostri beneamati Napoletano e Prodi e dalla leadership della Merkel.
Con questi discorsi si è però perso di vista il problema purtroppo contingente dei migranti (il 30 giugno ne sono arrivati 402 anche nel nostro porto). Se, come è umano che sia, continuiamo a salvarli e il resto dell’Europa continua a rifiutarli, cosa ne facciamo?
Prendiamo atto che l’Italia, per una serie di motivi, non fa figli. Questo significa che degli immigrati noi abbiamo bisogno. Altrimenti nel giro di pochi decenni la nostra economia si fermerà e saremo condannati a divenire una società di vecchi poveri, senza pensione e priva di quella creatività che tutto il mondo ancora c’invidia.
E siccome non vogliamo che ciò avvenga, insieme alla soluzione del traffico di emigranti, si deve pensare a facilitare il loro inserimento nella nostra società. Il che vuol dire conservare le nostre consuetudini e costumi e continuare a godere degli standard di sicurezza e di un livello passabile di decoro urbano. In altre parole c’è bisogno di una necessaria integrazione.
Naturalmente questo presuppone che, a monte, cambi l’atteggiamento dell’Europa nei confronti dei migranti. Se così non sarà dovremo fare nostra la definizione data dagli scrittori europei presenti nei giorni scorsi a Firenze in occasione del Festival von Rezzori. Senza mezzi termini hanno sentenziato che l’“Europa è una bugia”.
Più precisamente la scrittrice Zadie Smith, nata a Londra nel 1974, ha affermato che «è solo in un minuscolo recinto di privilegiati che si è formata l’idea artificiale ed esclusiva di Europa». Ed il francese Édouard Louis (classe 1992) ha aggiunto: «L’identità europea è fondata sulla distruzione. L’Unione stessa si è definita sull’esclusione di ciò che non è europeo, come i migranti che annegano nel Mediterraneo».
Insomma, sia a destra che a sinistra, si lamenta il tradimento di un sogno. E questo non sarebbe di per sé sufficiente per chiudere con questo tipo di Europa tanto diversa da quella che ci era stata promessa?
Guido Giampietro

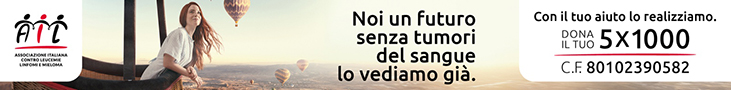



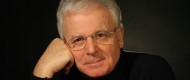



No Comments